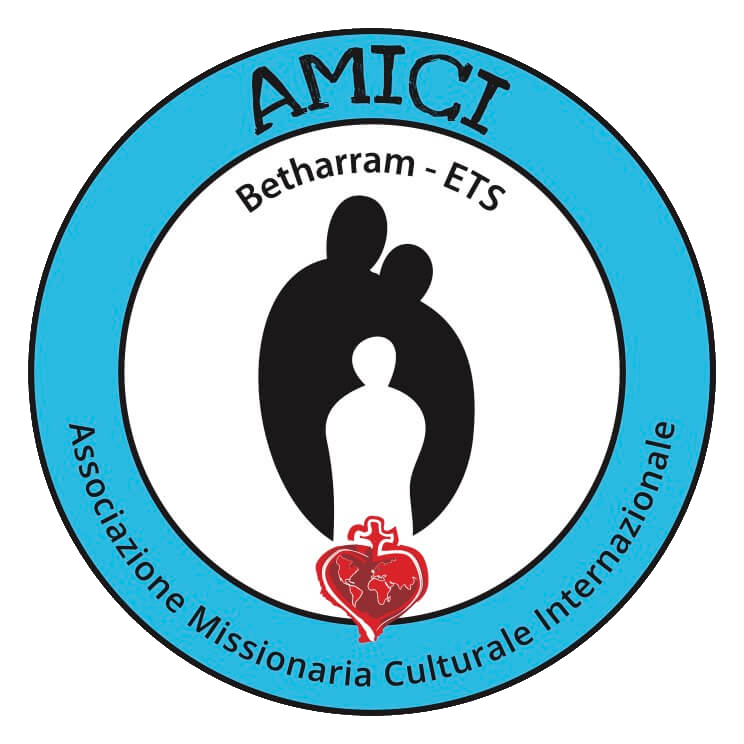Volontariato é: #inviaggioconmanuel: “Una domenica con padre Arialdo”
Da Livigno a Niem, dalla romantica e turistica città delle Alpi al cuore dell’Africa: questo è il viaggio di Manuel, partito come volontario nelle missioni betharramite il 14 gennaio scorso.
Dopo cinque esperienze di volontariato in Zambia, Manuel ha scelto il Centrafrica: vi resterà per due mesi per aiutare i lavori di costruzione della sala operatoria presso l’ospedale di Niem (Progetto “Londo mo Tambula”). Ecco alcune pagine del suo diario di viaggio.
Domenica mattina. Accompagno padre Arialdo a visitare uno dei villaggi della sua parrocchia, che si estende per oltre cento chilometri. Facciamo partire la jeep a spinta perché la batteria, oggi, non se la sente di farlo da sola. Per farsi un’idea del paesaggio basta vedere i primi duecento metri: visti quelli, si sono visti tutti. Una lingua di terra rossa dritta come se fosse stata tracciata con un righello e non più larga di tre metri su cui si chiude una vegetazione fittissima. E poi buche, buche ovunque. Deve essere molto robusta la jeep di Arialdo per resistere ad un viaggio così.
Ogni tanto la vegetazione si interrompe quel tanto che basta per fare spazio a piccoli villaggi con le capanne in mattoni e il tetto in paglia. I più grandi possono vantare anche una chiesa, una scuola o una piccola farmacia; per tutti gli altri villaggi è già un successo avere un nome.
Siamo nel villaggio che ospita il municipio di Niem e zone limitrofe. In alto, sulla collina, padre Arialdo mi indica il rifugio dei ribelli. Sono partiti stamattina in tre per ogni moto: in tutto erano una ventina, pronti per andare a fare la guerra. In piazza c’è il sindaco che non salutiamo, perché c’è un contenzioso aperto con padre Arialdo. Poco oltre un campo profughi deserto, voluto dagli arabi quando sono scoppiati i primi disordini: nessuno però ci vuole abitare, così è diventato patria delle termiti. Finalmente a metà mattina arriviamo al villaggio. Fermiamo la jeep di fronte alla piccola chiesa, miracolosamente in mezzo al nulla. Una torma di bambini circonda il mezzo, si accalca intorno a noi e mi fissano. Lo faranno per tutta la mattina.
Padre Arialdo tira fuori da una valigia di tela l’occorrente per la messa. C’è poca gente. È venuta a mancare una donna e sono tutti a casa sua, vorrebbero anche venire a messa, ma quando c’è un defunto bisogna rimanere al suo capezzale; chi manca è considerato implicato nella sua morte: credenze locali a cui non si può controbattere. Dopo qualche trattativa si giunge ad un accordo: la messa si fa e al termine porteranno la defunta per la benedizione prima di dargli sepoltura. Canti e tamburi: le messe africane, uguali praticamente ovunque.
Ed ecco che arriva la defunta trasportata con un carretto, accompagnata da una processione di donne urlanti e uomini piangenti: non ci stanno tutti in chiesa, qualcuno rimane fuori. Le urla e i pianti si mischiano ai canti. Paradossalmente è tutto un tripudio di colori di vesti e di fiori. Viene fatta la benedizione, un ragazzo entra con un rametto per misurare l’altezza della cassa della defunta e poi corre fuori a comunicare la misura a quelli che stanno scavando la fossa, quando la buca sarà pronta la seppelliranno. Prima di lasciare il villaggio ci accompagnano nella casa del vedovo, dobbiamo fermarci a mangiare qualcosa, così vuole l’educazione. Un tavolino basso con due panche, un secchio d’acqua per lavarsi le mani prima di mangiare e un pentolone pieno di manioca con un pentolino di carne di vacca in cui intingerla. La manioca non è altro che una specie di polenta insipida e appiccicosa che si prende con le mani, si appallottola e si intinge nel sughetto della carne per darle sapore. Ripartiamo con la pancia piena, su una jeep che è più piena dell’andata con gente che chiede un passaggio verso villaggi distanti qualche chilometro, su questa lingua di terra piena di buche e bruciata dal sole (se piovesse sarebbe solo un mare di fango capace di inghiottire la jeep come sabbie mobili…)
Pensavo con un retrogusto di amarezza a queste cose, poi, come mi avessero preso a calci per farmi alzare dalla sedia, sono uscito dai miei pensieri e mi sono avvicinato al bene più prezioso del Centrafrica, che non è né l’oro, né i diamanti: sono i bambini. Uguali in ogni angolo d’Africa.
Non me la sentivo di rincorrerli e inseguirli sotto il torrido sole, mi accontentavo di guardare un gruppetto giocare a calcio con una pallina non più grande di quelle da tennis, all’ombra di un albero appoggiato al suo tronco. Quelli più coraggiosi sono quelli più piccoli che si avvicinano guardinghi, allungano una mano, sfiorano braccia e capelli e nel mio caso la barba; e se non vengono mangiati, allora a quel punto capiscono che possono sedersi in braccio. È una regola fondamentale dell’Africa! Non la si studia nella facoltà di fisica, ma è una legge altrettanto reale della termodinamica. Un’altra legge è che quelli più grandi ti approcciano con il linguaggio universale e “rotondo” del calcio, senza giri di parole. La serata volge al termine, mi ci è voluta una doccia fresca per riprendermi.
Per la prima volta mi sembra che l’Africa sia al suo posto, lì dove l’ho conosciuta la prima volta.
Manuel Viviani