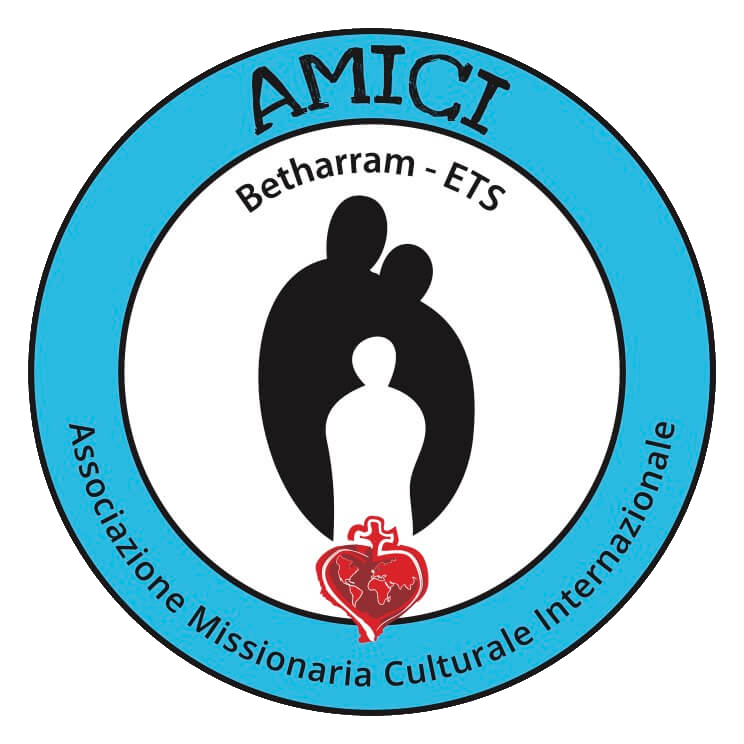Volontariato é: Maurizio “Ecco il mio bagaglio pieno di Amore”
Per la rubrica Volontariato è, oggi tocca alla testimonianza di Maurizio Garreffa, amico delle missioni betharramite in Repubblica Centrafricana. Maurizio è un giornalista che vive a Chiavari e lavora per l’emittente televisiva Teleradiopace.
Quando l’aereo virò per atterrare, dal finestrino alla mia sinistra apparve la pianura centrafricana ancora addormentata nelle prime ore del mattino, il nastro argentato del fiume Oubangui adagiato sopra come una cravatta spiegazzata. Sembrava di guardare un cielo rovesciato: i fuocherelli all’esterno delle capanne tremolavano come stelle in quella distesa di oscurità, da cui si intravedeva il profilo di una natura sconfinata. “Ecco, sono in Africa” pensai con emozione e paura. Non avrei mai creduto che una sola immagine così semplice, poco dettagliata, potesse strappare al mio cuore il primo battito d’amore per quel Paese ancora sconosciuto, la Repubblica Centrafricana. L’aereo si posò sulla pista di Bangui che il sole stava sorgendo. Nel parcheggio del piccolo aeroporto mi aspettava padre Beniamino, un rapido saluto, un sorriso di benvenuto e via.
Iniziava così un’avventura di quindici giorni con la famiglia dei betharramiti. La particolarità della missione è che si trova nel cuore di Bouar. I missionari sono a contatto con la gente dall’alba al tramonto e gli ospiti vengono travolti dal ritmo africano. Così è stato per me.
Non posso fare a meno di ricordare con nostalgia la vita del paese, l’esplosione di colori negli abiti delle donne, le nuvole di polvere rossa alzate dalle motociclette ad ogni loro passaggio, il vociare del mercato incuneato tra case e minuscole botteghe lungo sottili viuzze, la coda dei bimbi alla pompa dell’acqua, i loro sguardi curiosi, le mani lanciate in aria a salutare: “Balao” mi dicevano, “ciao”, rispondevo io, “Mercì” rispondevano in coro.
Ricordo tutto questo e sento ancora il caldo sapore della terra e la pungente fragranza della manioca lasciata ad asciugare sulla strada. Mi piace partire da questi aspetti perché per me rappresentano il segno di una Chiesa missionaria immersa nella vita della città, a contatto con le persone, con le loro tradizioni, i loro difetti, le loro credenze, i loro spazi. Una Chiesa capace non di imporre i propri giudizi, ma desiderosa di condividere e forse anche di imparare da quel popolo così bisognoso.
Certo, anche i ricordi difficili sono ben presenti. L’angoscia di persone imprigionate ingiustamente, vittime di giudizi frettolosi e superficiali, costrette a mangiare due volte alla settimana in un carcere poverissimo. Il dolore negli occhi di tanti bambini malati, alcuni ricoverati dopo essere caduti nel fuoco, altri per tubercolosi, per gravi anemie, per piaghe profonde. E le ingiustizie, che toccano tutti i settori della società. Ancora oggi quella sofferenza mi stringe il cuore con le sue dita fredde. Di fronte a tutto questo, però, i missionari scendono in campo ogni giorno con coraggio e con la voglia di aiutare senza fare distinzioni.
Nei miei pochi giorni di permanenza ho potuto vedere alcuni dei progetti portati avanti dai padri betharramiti e rendermi conto del loro infaticabile lavoro per migliorare la situazione. Forse è la classica goccia nel mare, ma la loro presenza viene riconosciuta e apprezzata dai centrafricani, e il loro modo di dire grazie, la loro accoglienza mi hanno commosso più di una volta.
Un pomeriggio, con padre Beniamino, caricammo la jeep e partimmo per Bangarem, un villaggio sperduto nella savana. Ottanta chilometri di nulla, avanzando a fatica tra le acacie abbattute dai fulmini, saltellando lungo vie improvvisate in mezzo all’erba, cercando l’equilibrio sui dossi scavati nella terra. Un viaggio difficile, completato con l’attraversamento di un fiume, che mi mise a dura prova. Avevo fame ed ero stanco, credevo che non avrei resistito. Eppure, quella gente così povera, ci accolse festosa e ci diede subito qualcosa da mangiare. Ci diedero un cesto che abbondava di arachidi, ed io mi sentii in colpa. “Nessuno è troppo povero per non donare qualcosa” e quella ne era la prova. Ecco perché, quando ricordo il villaggio di Bangarem, non vedo solo la povertà e la sofferenza, le difficoltà, la malnutrizione e la scarsa igiene. Quasi mi sono scordato d’aver avuto paura di dormire lì o d’aver mangiato al buio selvaggina sconosciuta. Se penso a Bangarem, vedo la gioia dei bambini che hanno cercato la mia mano e mi hanno mostrato senza paura il loro volto, la loto vita, le loro capanne, così povere di giocattoli, ma così ricche di umanità. Rivedo quelle arachidi, ancora tiepide del sole e delle mani che le avevano raccolte. Ne sento il profumo, la fragranza di tutti i miei limiti. Mi ritorna in mente anche la gioia della famiglia che ci ha ospitati dandoci quello che avevano preparato per cena. Il giorno dopo, lasciando il villaggio, seguii con gli occhi la scia dei bambini che rincorrevano la jeep come a volerla trattenere, e capii che quella di padre Beniamino non era ostinazione, ma il desiderio di un padre che incontra i suoi figli, anche se lontani, anche se a prima vista non ne varrebbe la pena. Un padre che condivide con loro la vita di tutti i giorni, che mangia con loro e dorme in mezzo a loro, anche se ad un estraneo può far paura o può sembrare incomprensibile. Un padre che ha l’umiltà di riconoscere che solo mettendosi al posto dei centrafricani è possibile muovere qualcosa di bello e sorprendente. Gli stessi progetti dei padri Betharramiti sono portati avanti in larga misura da centrafricani, affinché possano piano piano responsabilizzarsi e prendere per mano la situazione che li circonda.
Ecco, tornando verso casa, di nuovo sull’aereo, ricordai un pensiero formulato alla partenza, due settimane prima: “Ho paura di andare in Africa”. Sapete, rientrando in Italia, di una cosa non avevo dubbi: la vera paura, adesso, era di ritornare in Europa. La paura di lasciare la semplicità e l’accoglienza dell’Africa, la schiettezza e il coraggio dei missionari. Al contrario dell’andata, il mio bagaglio viaggiava vuoto e leggero, ma il bagaglio del mio cuore era colmo dei volti di tante persone che chiedevano di essere custoditi, di domande che chiedevano di non essere dimenticate e di esperienze che avevano già deciso che non sarei stato più il ragazzo di prima.
Maurizio Garreffa